Come si costruiscono degli archivi (davvero) utili
Tutto il mio tempo mi sembra sprecato, come posso restituirgli del senso? Una conversazione con Silvio Lorusso.
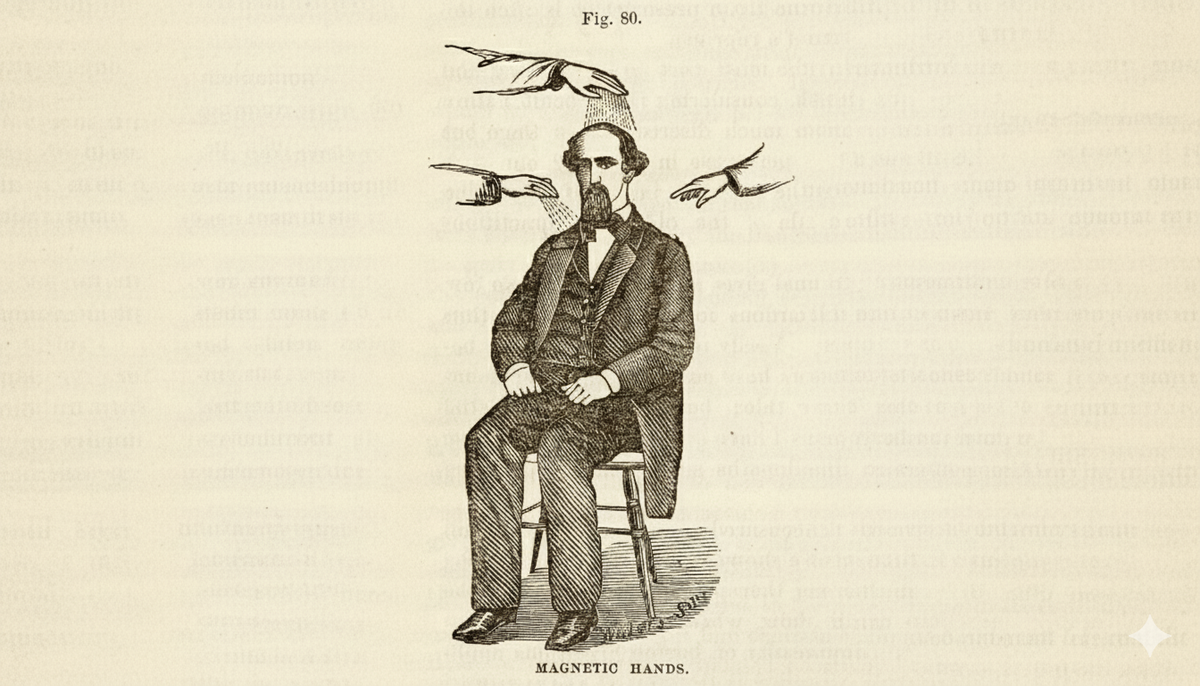
Questo articolo è stato scritto e pubblicato per la Issue 2: Care di Vivo Journal.
Ogni secondo che passo a produrre, mi sembra un secondo di vita sprecato. È per questo che sono ossessionato dall’efficacia delle mie azioni. Non parlo di ottimizzazione e produttività, parlo di fare lo stretto indispensabile: ridurre il rumore e generare efficacia.
Ci sono, fortunatamente, dei momenti di silenzio che intercorrono in questi pensieri intrusivi. Pensieri che di fatto mi impediscono di lavorare, facendomi sprecare ancora più tempo e aumentando a dismisura il mio senso di frustrazione.
Ecco, l’ultimo di questi siparietti ha come protagonista me stesso, e come oggetto dell’opera un desiderio: voglio costruire un server casalingo che contenga, tra le altre cose, un archivio condiviso di materiali multimediali da condividere e costruire con le mie amiche e i miei amici.
Sospendiamo il giudizio sul perché voglia fare una cosa del genere. Come si costruisce un buon archivio? Ovvero pratico, utile, in grado di arrivare al punto senza tralasciare le sue caratteristiche essenziali?
Parlando proprio di efficacia, mi basta confessare che dall’inizio di questa avventura (diverse settimane fa), ho speso la maggior parte del tempo a scegliere e a cercare di far funzionare la piattaforma open-source su cui vorrei ospitare il blog di questo archivio. Per ora, di indici o cataloghi, neanche l’ombra.
Non ho intenzione di rendermi efficace proprio ora. Invece, ho intrattenuto qualche scambio con Silvio Lorusso, scrittore, artista e designer. Autore di diversi testi che, tra le altre cose, riflettono sul significato di efficacia.
Abbiamo iniziato cercando di semantizzare il senso dell’efficacia.
Silvio Lorusso - 22 luglio 2024, 18:50
“La parola efficacia mi affascina perché si differenzia dall'efficienza forse per una specie di pienezza (lo dice Treccani, non io) che quest'ultima non ha.
Non sarei invece così netto con l'equivalenza tra la concentrazione e l'attenzione. La concentrazione, sebbene necessaria, è essa stessa una forma di ottimizzazione delle risorse cognitive, mentre l'attenzione è un'apertura che credo possa contemplare persino la distrazione. Guarda caso, ho per sfondo del desktop una citazione di Simone Weil, che ha dedicato molte parole alla pratica dell'attenzione. Eccola:
La volontà, quella che, se occorre fa stringere i denti e sopportare la sofferenza, è lo strumento principale dell’apprendista nel lavoro manuale. Ma contrariamente all’opinione comune, nello studio è quasi irrilevante. L’intelligenza può essere guidata soltanto dal desiderio. E perché ci sia desiderio, devono esserci piacere e gioia. L’intelligenza cresce e porta frutti solo nella gioia. La gioia di apprendere è indispensabile agli studi come la respirazione ai corridori. Dove è assente non ci sono studenti, ma povere caricature di apprendisti che al termine del loro apprendistato non avranno neppure un mestiere.
Poco prima: "Negli studi vi è spesso dispendio di un simile sforzo muscolare. E poiché alla fine ci si sente stanchi, si ha l’impressione di aver lavorato. Ma è un’illusione." Quello sforzo muscolare è la concentrazione.
Ho passato gli ultimi mesi della mia vita a chiedermi dove fosse finita la mia concentrazione. All’inizio di settembre, ho speso settimane a intere a tentare di concentrarmi per qualche ora, architettando diversivi diplomatici e servendo scuse improbabili a clienti e amici.
Non ho dubbi su ciò che devo fare, né tantomeno su come farlo. Non appena inizio a fare quel qualcosa, mi distraggo. Non parlo di stanchezza o di impulsi esterni. Millisecondi di attività prima che i miei pensieri vadano altrove, incontrollabili. Rifiuto di pensare che si tratti di un disturbo dell’attenzione, sono già depresso. Probabilmente sono solo stronzo, indisciplinato, viziato.
L’unica cosa che sono riuscito e che riesco a fare con naturalezza, è lavorare a questo maledetto archivio. Decine di ore consecutive di concentrazione sacra. Quale strumento, quali fasi, chi coinvolgere, perché, quando. Pensiero che diventa progetto, progetto che rende il pensiero efficace anziché arrugginirlo. Mi sono detto, proprio con volontà di efficacia, di concentrarmi su ciò che mi viene naturale. Così, insieme a Silvio, abbiamo continuato. Come si fa un buon archivio?
Silvio Lorusso - 3 ottobre 2024, 14:45
Un buon archivio fa tre cose: preserva, struttura e soprattutto – a costo di violare un tabù contemporaneo – esclude.
Senza esclusione si entra nei deliri borgesiani di biblioteche che contengono tutti i libri possibili e immaginabili, di mappe così grandi da coincidere con il territorio e di generale panico apofenico. Senza esclusione diventa difficile anche preservare, e non solo nel mondo fisico, dove i metri quadri scarseggiano, ma anche in quello digitale, dove la tentazione di accumulare gigabyte su gigabyte è forte.
Come si archivia, ad esempio, un libro d'artista? È sufficiente scannerizzare tutte le pagine? Non sarebbe utile fotografare anche il dorso o il taglio? E che dire del modo in cui tale libro è usato? Non dovremmo anche filmare un lettore mentre lo sfoglia?
In Italia, Federico Novaro aveva affrontato il problema nel suo blog, risolvendolo in maniera per così dire sentimentale, ovvero indugiando su alcuni dettagli toccanti, oltre che, com'è più scontato, su copertina, quarta ed eventualmente alette. L'esclusione è in fondo inevitabile, ma provoca nevrosi quando è inconsapevole o rimossa.
Credo che, in un certo senso, le riflessioni sull’efficacia siano tautologiche. Sono attuabili solo quando calate nella pratica, prima tendono alla rarefazione: disperdono il pensiero, anziché concentrarlo. Lorusso ha fatto un archivio: Post-Digital Publishing Archive.
L'idea chiave di P-DPA è nella pagina dedicata agli indici. Trattandosi di un archivio dedicato a progetti di editoria sperimentale a cavallo tra il digitale e l'analogico era abbastanza ovvio includere i media (dall'email alla lastra in pietra) e le tecnologie (dal ciclostile alle gif animate); per quanto, anche lì, sorgono dei problemi, dato che lo stesso alfabeto è a tutti gli effetti una tecnologia). Meno scontato era invece il focus sulle piattaforme, da cui la maggior parte di progetti che mi interessavano dipendono e senza le quali non esisterebbero. Un esempio fra i tanti: American Psycho di Mimi Cabell e Jason Huff (2011). Questo paperback è stato realizzato inviando l'intero capolavoro di Bret Easton Ellis, pagina per pagina, tramite due account Gmail. Gli artisti hanno dunque salvato gli annunci relativi a ciascuna pagina e li hanno aggiunti al testo sotto forma di note. In totale hanno raccolto oltre 800 annunci che gettano luce – obliquamente – sul contenuto del romanzo in assenza del testo originale.
Come sostengono Cabell e Huff, "questa ricostruzione rivela l'imprevedibile insensibilità di Gmail nei confronti della violenza, del razzismo e del sesso. È un ritratto sfocato di un algoritmo che esiste nella nostra comunicazione quotidiana e contemporaneamente forma un nuovo ritratto del protagonista, Patrick Bateman."
In tal senso, P-DPA si può considerare un archivio di tattiche d'intervento rispetto alla logica delle piattaforme e, passato un po' di tempo, anche una archeologia di queste stesse piattaforme.
Resta chiaro che l’unica strada che porta all’efficacia passi, necessariamente, dall’inefficacia. Fare troppo e fare male, così tanto da doversi infine rendere conto di questa mancanza. Accettarla, e accettare soprattutto quanto si debba ancora imparare di meno, non di più. Costruire un archivio significa, talvolta, sgrassare: eliminare il superfluo e assottigliare la strada. Osservare il mondo abbandonando una prospettiva di romantica complessità, e adottare — tragicamente — un rassegnato pragmatismo.
Non sono ancora riuscito a trovare il tempo – dopo diversi anni! – per caricare tutti i vari progetti discussi nella mia tesi di dottorato, di cui P-DPA è un sottoprodotto. Delle opere che posseggo materialmente, la maggior parte sono lì, ad accumulare polvere, sugli scaffali di casa di papà. Da questo fallimento tuttora in corso credo di aver imparato una lezione: non reinventare la ruota. Prima di sviluppare il tuo complesso sistema custom di gestione dell'archivio (come ho fatto io, ed è un miracolo che sia tuttora online), dai un'occhiata a ciò che è già disponibile. Prima di cominciare a conservare in maniera amatoriale libri e opere, chiediti se c'è qualche istituzione disposta a collaborare con te. Prima di creare una nuova "ontologia" per la tua collezione esamina quelle esistenti. Questo lavoro io l'ho svolto solo in parte, e in verità ne è valsa la pena, dato che mi ha costretto a imparare molto. Però, d'altra parte, sento di non aver chiuso del tutto i conti con l'archivio. Mi consolo pensando che in fondo non ho voglia di farlo, perché P-DPA mi fa compagnia.